Home
A COMPAGNA
A-O PAXO IN ZENEIZE
Domenica 27 giugno 2012 alle ore 15.30 nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale
l'associazione A Compagna offre alla cittadinanza lo spettacolo
A-o Paxo in zeneize
(A Palazzo Ducale in genovese)
Ingresso gratuito
Sono disponibili 140 posti a sedere
Le regole del Covid ci impongono di assegnare i 140 posti a sedere su prenotazione per “tracciare” le presenze. Chi desidera partecipare deve prenotarsi all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonicamente allo 010-246.9925 (segreteria telefonica) indicando nome e cognome dei singoli partecipanti e, per ognuno, un recapito telefonico. Completati i 140 posti non sarà più possibile accettare prenotazioni ulteriori. Le persone prenotate devono presentarsi domenica 27 giugno a Palazzo Ducale, farsi identificare e sedersi nel posto assegnato.
Partecipiamo in tanti: non lasciamo posti vuoti!
Tutti gli anni per la ricorrenza di San Giorgio, santo patrono dei Genovesi (23 aprile), A Compagna organizza uno spettacolo che vuol riproporre momenti della tradizione genovese con canti dialettali in costume, musiche genovesi e liguri e intrattenimenti in genovese.
Gli artisti che animeranno lo spettacolo sono i seguenti.
Il Gruppo Folcloristico Città di Genova accoglierà gli intervenuti con antichi canti genovesi ed i costumi della tradizione popolare.
Marco Rinaldi ci intratterrà con il suo irresistibile cabaret.
Zena Singers Band che ci proporranno, con la formula del teatro/canzone, alcuni brani dei cantautori genovesi.
Davide De Muro, ottimo chitarrista, ci presenterà le novità nella musica genovese moderna.
Alessandro De Muro, valente chitarrista e cantautore, ci presenterà alcune sue canzoni.
Ospiti d’onore:
Piero Parodi, il più autorevole rappresentante della musica genovese,
Vladi dei Trilli, erede del duo più famoso della canzone genovese: i Trilli,
Massimo Morini dei Buio Pesto che ha avvicinato molti giovani alla musica genovese.
La conclusione come sempre è affidata al Gruppo folcloristico Città di Genova per un finale musicale brillante, allegro e divertente.
Lo spettacolo è realizzato con la partecipazione gratuita di tutti gli artisti e con il contributo di "Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura" che A Compagna volentieri ringrazia.
L’Annuario Genovese
Articolo pubblicato sul bollettino n° 7 – ottobre 1928
L’Annuario Genovese (l’antica guida del signor Regina) entra nel suo 114 anno di vita con la edizione testé uscita. La pubblicazione che oramai è considerata una vera e propria istituzione genovese dice giustamente nella sua prefazione: “Sotto la nuova veste abbiamo potuto ampliare ancora il nostro lavoro fino a raggiungere la mole di una pubblicazione il cui valore è ormai riconosciuto da tutti e ci è fonte di orgoglio e sprone a migliorare sempre. Non crediamo possa sfuggire neanche ai più distratti osservatori il lavoro da noi compiuto per la edizione che stiamo presentando, e solo che si vogliano considerare tutti i cambiamenti nelle Istituzioni che il Regime va continuamente sviluppando, e la cui impronta abbiamo ben fissata in tutta l’estensione maggiore, interpretando fino all’essenza dello spirito le alte idealità del Fascismo, che vanno concretandosi secondo le direttive del Governo; potrà essere valutato al suo giusto valore l’immane lavoro da noi compiuto al solo scopo di conferire una importanza sempre maggiore alla nostra pubblicazione, aggravandosi sempre più di spese e di fatiche. Ed anziché sfoggiare od ostentare il nostro aumento di volume, abbiamo cercato di concentrare la materia scegliendo i caratteri più minuti.
Il lettore troverà nella parte amministrativa registrate dettagliatamente tutte le nuove Gerarchie del Partito Nazionale Fascista, l’Opera Nazionale Dopolavoro, l’Opera Nazionale Balilla, tutti i Sindacati dei Datori di Lavoro distinti nelle singole Federazioni e Sezioni come i Sindacati dei Lavoratori con tutte le indicazioni delle Sezioni dipendenti.
Gli Usi Mercantili che si osservano sulla piazza di Genova sono stati elencati secondo il nuovo ordine stabilito dal locale Consiglio Provinciale dell’Economia e la ricchezza delle voci di richiamo dei due Indici rendono facilissima la ricerca di ogni Uso. Nuove per questa edizione e che seguono immediatamente gli “Usi” sono le “Regole di York e di Anversa, 1924” testo eminentemente marinaro, che interessa la nostra città, eminentemente “marinara”.
Il volume, che comprende oltre 2100 pagine, è una preziosa guida per tutti e sommo suo pregio è quello della massima diligenza in fatto di indirizzi e delle più disparate indicazioni.
Sinceramente ci congratuliamo coll’egregio direttore dell’Annuario Genovese, signor Vincenzo Tagini, pel grado di perfezione al quale ha saputo condurre la pubblicazione a lui affidata dai fratelli Pagano.
_______________________________
Il Lunario del Signor Regina
Articolo a firma Emanuele Canesi, pubblicato sul bollettino n° 9 – dicembre 1928
Il signor Vincenzo Tagini, che dirige la secolare pubblicazione dei Fratelli Pagano, ha voluto farmi gentile omaggio dell’Annuario Genovese 1928-1929: un volumone che guai a lasciarselo cascare sulla punta dei piedi e che, rosso e grosso com’è, potrebbe anche far pensare a uno di quei taxi i quali oggidì formano il terrore del vile pedone in procinto d’avventurarsi nel tragitto che corre dal Teatro Carlo Felice all’imbocco di Vico Casana.
Oh quantum mutatus ab illo! Quale processo di crescenza, voglio dire, da quel che fu il Lunario del Signor Regina, poco più grande, nel formato, della Divina Commedia in edizione Diamante: emporio di profezie chiaravallesche, di barzellette, di epigrammi, di satire, di raccontini, guazzabuglio di pasquinate e di notiziole date tra il serio e il faceto; ma, quanto ad informazioni di pratica utilità in genere e a indicazioni di toponomastica cittadina in ispecie, zero, quando non si voglia tener conto della parte in cui è segnalato il genetliaco di Carlo Felice Re di Sardegna e dei Principi di Casa Savoia; la composizione delle pubbliche amministrazioni; i membri della Camera di Commercio; i varvassori della nobiltà e del clero e – cosa davvero importante, l’arrivo e la partenza dei corrieri:
CORRIERE Dl TORINO
Arrivo: Lunedi, Mercoledì e Venerdì, alla matt. colle lettere del Piemonte, Savoja, Svizzera, Francia, Olanda, Inghilterra, Spagna, Portogallo, ecc.
Parte: Lunedì, Giovedì e Sabato a 5 ore pomeridiane.
PARTENZA E ARRIVO DELLA DILIGENZA
Parte: Domenica alle ore 9 precise di matt. per la Lombardia e la Romagna, passando per Milano – Martedì, Giovedi e Sabato alle ore 4 di mattina per il Piemonte e la Francia.
Arrivo: Lunedì, alla mattina dalla Lombardia e dalla Romagna passando per Milano, Venerdì e Domenica alla mattina dal Piemonte e la Francia.
IL FRONTESPIZIO DELL’ANNO 1820
Ah, quel delizioso viaggiare pigiati, quasi impiombati entro l’arca spaventosa della diligenza, dopo il risveglio ante lucem, l’attesa nella rimessa, l’appello, la visita, il controllo... Ma si parte, a Dio piacendo, e via di galoppo in mezzo alla campagna, col sole che vi arrostisce, il polverone che vi accieca, le groppe dei cavalli che nello sforzo del traino vi salutano a ripetizione di colubrina, e nella dolce compagnia – putacaso – d’una madama franciosa tutta cincischi, tutta cernecchi, crepitàcolo di chiacchiere con lo spruzzo, che viaggia con la scimmia e il pappagallo; d’un Tedesco che fuma come un Sultano
Çerta fèuggia de marocco
Ch’a l’aspûssa de merdocco
(E de quello vermentin!...);
d’un Lombardo ciccioso, bracalone, che stronfia e ridacchia sconocchiandosi pingui provviste di mortadella e piacentino; d’un Inglese stirato sulle quattro punte, accigliato, infastidito, scocciato, che va ruminando goddemme e lamenti:
Con scì bella compagnia
Chi no staiva in allegria?
Mi ve lascio conscideâ!
Che belliscimo viaggià!...
Chi dormiva, chi runfava,
Chi tombando pizaggiava,
Chi reûtava, chi tosciva,
Chi stranûava, chi s’arviva,
Chi sospiava, e con rispetto
Solfezzava o sospiretto...
Azzunzeighe a mûxichetta
De cagnette e da scimietta,
Che sbraggiavan affammæ
Pe-i zazûin no comandæ.
O fischiâ do pappagallo,
O nitrî ogni pö ûn cavallo.
A carrossa chi scrosciva,
(E mi ammiavo se a s’arviva)
O lucciâ de due chitare
Prüxe grosse comme giare,
O Sô in lion, mosche azenin-ne,
Tanti fiati a-o streito insemme
Donne, bestie, ommi, giastemme,
Mi n’aveivo e stacche pin-ne,
E se n’êa pe-a convenienza
Davo o vaso ä Diligenza,
E me-a favo sempre a pê
Comme fà patron Carcagno
Bon-nasêua cö so compagno;
Finalmente, lode a-o Çê,
Emmo dæto fondo a Nêuve
Che s’ëa giùsto misso a ciêuve,
Né a me parsa manco vëa
De levâme d’in galëa.
Chì ghe saiva da inciastrâ
Un-na risma de pappê
A voei tùtto ben contâ,
L’invexendo di foestê,
L’imbarasso, e l’impazienza,
Che gh’ëa l’atra Diligenza
Chi vegniva da Milan
Pe andâ a Zena all’indoman;
Quanto sciato, e che caladda
Fan due Diligenze in stradda!
No ve conto ûn-na fandonia,
Paiva un’atra Babilonia
Co-a burasca che s’ëa mísso
D’ægua, vento, lampi, troìn,
Gragnêua grossa, oh che pastisso!
E che armâ d’invexendoin!
Chi dixeíva “ja”, chi “oui”,
Chi sbraggiava “ies”, chi “scì”,
Chi montava, chi chinava
Con passâ sotto i cavalli,
Chi ûn fangotto rebellava,
Rattellando co-i camalli,.
A sentî Madamma criâ
A-e sò bestie: “vite”, “allons”, [presto, andiamo, n.d.r.]
“Mes enfants”, “mon perroquet...” [bambini miei, pappagallo mio, n.d.r.]
E rispondighe un garçon:
“Son qua mi lo perrucchê,
No s’arraggi, Sciô Monsù,
Che ghe a taggio in t’un momento”.
Da-o gran rie no poeívo ciù,
E de veddia co-a chitâra
Sciortî fêua, a paiva a bazâra. [Befana, n.d.r.]
VIGNETTA DELL’ANNO 1820
Questo quadretto di vita irresistibilmente brioso e dinamico, l’ho appunto trascritto da uno di quei libercoli nei quali si sbizzarriva la Musa casalinga del nostro massimo poeta dialettale Martin Piaggio, o sciô Regin-na, pseudonimo che gli rimase appiccicato come una camicia di Nesso. Essi furono il veicolo della sua inesauribile vena di motteggiatore, di censore, di cronista. E in quello dell’anno precedente (1828) i lettori del Lunario, con la tenue spesa di poche scagge [monete antiche genovesi che valevano due soldi, n.d.r.], avevano potuto bearsi alle avventure aeronautiche del Sciô Martin, che per divertirli s’era cimentato a un immaginario viaggio in pallone, da Genova ai Bagni d’Acqui:
Fæto o primmo mæ viaggetto
In te nûvee angosciosetto
Pe-a grand’aja c’ho collòu,
E pe-o freido remondòu,
C’un pittín de scagabuggia [paura, n.d.r.],
Perché ho visto a Lûn-na duggia,
Tûtte e stelle cheite in mâ
Lûxî o Sô sens’ascadâ
Son stracuòu [sono stato trasportato, n.d.r.] con l’ancoa e o pægua,
Ma per miacoo salvo e san
In t’ûn porto dov’é un’ægua
Che chi a tocca a peja a man,
E a chi a piggia refreidâ,
A no fà né ben, né mâ.
E chi incontra lassù, alle famose terme aleramiche? Tutto un campionario di umanità in riparazione accorsavi a chiedere panacea ad acciacchi d’ogni natura e gradazione, ch’egli guarda con l’occhio dell’umorista, affermando che, se il Tasso avesse ficcato quella gente nel suo Bosco incantato, persino Rinaldo, in vederla, se la sarebbe battuta:
Ommi, donne, figgiêu, fratti,
Prævi, muneghe, sordatti
D’ogni etæ, d’ogni nazion,
D’ogni stato e condizion,
E o se pêu a raxon ciammâ
Un brillante e triste Uspiâ
Pe-a stranezza de maottie
Che fan proprio cianze e rie.
Lì gh’é sempre societæ
D’ommi intreghi e retaggiæ,
E de donne belle e brûtte,
Ma coa camoa quæxi tûtte.
Vegi e zuveni che van
Tûtti a un moddo differente;
Chi ranghezza, chi va cian,
Chi fà fô, chi no se sente,
Chi va drito, chi sciarròu,
Chi va a lorsa, chi arrembòu,
Chi a sätetti, chi in gatton,
Chi co-e scrosue [stampelle, n.d.r.] , chi ha o baston.
Lazzù spunta dui a brassetto?...
Pän scappæ da-o cattaletto!
Là ghe n’é ûn chi è cô do cöu
Chi va in caraghetta d’öu:
Questo o portan in spalletta
Tûtto ascôso in ta berretta,
Quello o l’ha e gambe cö trillo,
L’atro o schitta comme un grillo;
Chi va redeno e instecchîo
Chi chinòu, chi arrensenio;
Chi è mezz’orbo, strambo [strabico, n.d.r.], o guerso,
Chi ha e bertelle de traverso.
ANNO 1830
Così, dal 1815 al 1843, ogni anno che spunta offre al nostro poeta l’opportunità di consegnare ai torchi – sull’esempio di Schiller e di Goethe – le sue estrose filastrocche non sempre informate alla fantasia pura, ma il più sovente ispirate a finalità didattiche o a scopi di evoluzione cittadina in tema di viabilità, di edilizia, di estetica, di profilassi. Il castigat ridendo mores è la sua divisa; ma le sue tirate non dànno l’idea della stoccata; hanno piuttosto l’importanza del buffetto sulla gota e del colpetto sulla pancia, di chi vuole sgonfiar vesciche o far rientrare rotondità boriose, senza peraltro levar le berze [calcagni, n.d.r.] o lasciare traccie di ecchimosi a chicchessia. Non l’individuo da ferire ha davanti a sé l’Esopo genovese quando stabilisce paralleli e tira conclusioni dalle sue favolette; ma l’umanità claudicante come il Diavolo Zoppo a cui bisognava massaggiare muscoli e nervi, non già stroncare gli arti infelici. Di certo i contemporanei, ai quali era ben nota la bonomia del poeta, che in foglietti manoscritti aveva già dispensato, senza economia, poesie e poesiole d’ogni risma e tenore; di certo devono aver atteso come un dono di pan pepato la pubblicazione del primo Lunario che Martin Piaggio, travestito da Scio Regin-na, (una macchietta genovese diventato maschera sul teatrino dell’ex chiesa di S. Paolo in Campetto, dopo essere stato nella vita un berteggiatore [schernitore, n.d.r.] crapulone) faceva precedere da questo sonetto-programma:
L’é duï anni che fan o bûrattin
Da mæ personn-a ai Teatri per fâ rie;
Me ficcan dappertùtto co-e poexìe
Per fâ o Puriscinella e l’Arlecchin.
Primma m’han rotto o collo a son de vin,
Son chi ä Foxe coi osse impûtridïe:
N’ho mai çercòu nisciùn!... me çercan mie?
L’é giûsto che me vendiche ûn pittin.
Sciscignore!... a l’é dita; êuggio stampâ,
Un Lûnaietto apposta con de “Foette”,
M’êuggio mi ascì a-e sò spalle ûn pö demoâ:
Fö mette ûn avviso in te gazzette,
E per despëto ô vêuggio regalâ,
De badda a chi spendiâ dozze scaggette.
ANNO 1833
In verità che, nel dare alla luce il suo annuale opuscoletto, cui fu culla la tipografia di Paolo Scionico e carriêu [girello, n.d.r.] quella dei Fratelli Pagano, il Piaggio si proponeva ben altra mira che non quella di solleticare i suoi lettori sotto le ascelle.
Mettere il dito dov’erano piaghe cittadine, questo egli voleva; applicare cataplasmi, fossero pur cosparsi di causticissima senape, dove c’erano bubboni da purgare: nella famiglia e nella pubblica cosa. In altri termini, tener vivo il fuoco delle buone tradizioni paesane e domestiche; promuovere l’amore alla patria terra; spronare o infrenare, a seconda dei casi i padri coscritti [senatori dell’antica Roma, n.d.r.] additando loro, mediante l’esercizio della libera critica, il bene comunale da promuovere e il male da estirpare. Né si rivolgeva ad essi direttamente, il peripatetico brontolone; ma, seguendo il dettame del ligure adagio: diggo a ti sêuxoa perché t’intendi ti nêua, s’era foggiata una ipotetica comare in Cattainetta, rivendugliola di noccioline ai crocevia, nel cui capace seno egli versava la piena dei giòliti [lieti riposi, n.d.r.] e delle amarezze della Musa vernacola:
Ghe sei stæta Cattainin
In sciâ Ciasasa là dä Posta?...
Presto andæghe ûn pittinin
E piggiæ magära a posta,
Che veddiei che travaggin
Che g’han fæto ben ideòu,
Da per tûtto lastregòu
Con disegni ä biscocchin-na;
No gh’é ciù de monta e chin-na,
Passeggiæ a vostro piaxei,
Sei a sosto de grondan-ne,
Che se, a Ciassa de “Fontan-ne”
Ciù ciammäla no poriei
Porrieì dighe di “Fossoei”,
Che da-o “Culisseo” Negron
Mi me pâ che gh’aggian bon.
Ma do resto, ca-a Comâ
Mi no parlo per livô,
Ma per zelo, e patrio amô;
Né pretendo scindicâ;
Coscì avessan rimediòu
A-e “Facciate”... che peccòu !
De lasciâ l’imbuccatûa
Do straddon “Carlo Feliçe”
Coscì misera, e infeliçe
Senza ûn pô d’architettûa!...
Da ogni parte che ve giæ
No veddei che Lûxernæ,
Tanabêuzi [bugigattoli, n.d.r.], Barconetti,
Fûmmajêu, Teiti, e Teitetti
Che ve fan proprio patî.
No ghe vêu miga ûn mjon
Per levâ sto preboggion
Comâ caa, cose ne dï?
“G’han a peixe ae parpaggíéue! [lo stesso che “scagge”, n.d.r.]”
Brava!... Dæme due nissêue.
Sei mai stæta a passegiâ
Lazzù verso San Teodöu?...
Mi ghe vaddo e me resciöu
De piggiâ l’aja de mâ;
Oh che vista sorprendente!
Da Cittæ e de tûtto o Porto!
Gh’é ûn continuo andâ de gente
(E de votte qualche morto!...)
Che se a fusse ben tegnûa,
Anacquâ e un pö ciù allunghïa,
A vegnieiva sciù bell’äta,
Sempre a l’ombra se passieiva,
E ciammâ allôa se porrieiva
Con raxon sta Passeggiata
“Deliziosa, varia e amena”
E gh’andieiva tûtto Zena
Ancon ciù che all’Accassêua...
Diggo ben? o diggo mâ?
Se no diggo ben, Comâ,
Dæme solo ûn-na nissêua.
Ma, v’avverto, se g’andæ
D’in Fossëlo no passæ.
Perché a stradda a l’é tappâ
Da di Banchi de Mersâ,
Da Corbon-ne de Terraggia,
Da Chinette de Limoìn,
Da Montagne de Meloìn,
Da Buzzûmmi [frutta acerba, n.d.r.] pe-a Canaggia,
E atri imbrummi [ingombri, n.d.r.] senza fin;
Ghe fan tûtti lì a sò tappa,
Gh’é ciù pesci che n’é in Ciappa.
Frûta, funzi, êuve, verdûa,
No se pêu passâ a drittûa.
Oh che brûtta tolleranza,
Vergognôsa pe-a Çittæ!
E che erroî de concordanza!
No se fan manco nee schêue...
Dæme ûn callao de nissêue [tre nocciole messe a triangolo, con una quarta sopra, n.d.r.].
Me dixeiva mæ Meziavo
Che voi Donne, Cattainin,
Ne sei un-na ciù che o diavo;
Dìme dunque ûn pittinin,
Che o saviei, perché raxon
Lascian stâ sempre in Çittæ
Tanti pöveì non nostræ,
E stroppiæ che fan ghignon [avversione, n.d.r.]?
E perché no son bandii
E a-i sò Paixi fæti andâ?...
Avanzieivan de levâ
Quelle poche parpaggiêue
A-i nostræ... Comâ? nissêue.
. . . . . . . . . . . .
Quello fûmme? che fortô!
Che negressa! e che spessô!
Tûtte e case o fa vegnî
Neigre comme i fûmmajêu,
Lonxi ûn miggio ve sentî
Palpitâ e mancâve o coêu,
Un-na cosa chi fà orrô!
Me pä d’ëse in sciû vapô,
E poi dixan che se meue!...
Dæme presto due nissêue.
E quelli atri caruggin,
D’immondizie sempre pin,
E che mai nisciùn ghe spassa?
Oh che spûssa maledetta!
A l’é tanta pæsta sccietta!
E poi dixan che se mêue!
Dæme torna due nissêue!
E quell’atra spassatûa.
In te stradde da Çittæ?
Figgi cai, che precisûa,
No pàn stæte mai spassæ,
Comâ caa, cose ne dî?
Piggian çerti professoî
Che de “netto” no s’intendan,
Coscì san dove piggiâla...
Ma ghe n’é proprio da rie?...
Due nissêue, ma brûstolie.
E... ma basta..., addio, Comâ,
Allûghæ tûtte e nissêue,
Che servian pe ûn’atra votta,
Dunque strenzo troppo a scotta
Stæme allegra, Cattainotta.
ANNO 1834
E il trionfale epicedio [canto funebre, n.d.r.] sulla fine delle grondaie ch’erano la sua ossessione, il segnacolo in vessillo dei suoi non sempre inascoltati “mugugni”? Eccolo:
Addio, Grondan-ne, addio!... vatte a negâ,
Stillicidio de Zena giastemmòu!
Che per fâte da-i teiti disertä.
Me ghe son per dex’anni spolmonòu,
Addio!... coscì porriö ûn pö passeggiâ,
Lûxindo o Sô, sens’ëse ciù bagnòu;
Addio!... porriö coscì o pægua serrâ,
Finïo de ciêuve e doppo avei nevòu;
Addio!... che sotto i “toæ” [tettoie, n.d.r.] ciù no passiö,
Tante “mostre” de fêua veddiö retiæ,
Né a-e bûttëghe all’“orbetto” ciù accattiö;
Addio Peschee, Barchî, Fontan-ne! andæ,
Passa o tempo, v’aggueito, e ve scorriö
Fin tanto che ne sei tûtte scentæ.
Ma il Lunario, alla guisa di tutti gli altri almanacchi d’allora e di poi, era fatto di cento altre quisquilie: aneddoti, massime, sentenze, indovinelli, e, per ogni mese, le sue brave previsioni meteorologiche e mondane, dove il vago ed innocuo pettegolezzo veniva condito di sali più o meno attici [arguzie, motti di spirito, n.d.r.]:
“È questo il mese (gennaio del 1828) più allegro per i disperati e il più tristo per chi ha denari e famiglia e dipendenti... e relazioni galanti. Gli uni danno e gli altri ricevono. Guai a voi, o avari! Quante pillole amare da trangugiare! Oh vi son pur delle mance di cui non potete far a meno. La noja delle visite va crescendo. I buoni augurj, le proteste di servitù, di amicizia, a fior di labbra più che mai. Il carnevale si annunzia bene. I balli pubblici saranno però più allegri de’ festini privati. Gran progetti di mascherate. Le vecchie, di solito, ameranno travestirsi da giovani e “vice versa”. Mariti all’erta! Due vedovelle offriranno materia alle ciarle de’ maligni... e i maligni daran nel segno. Disperazioni e pazzie d’una moglie golosa. Vedrà la luce una nuova commedia che farà furore. Avrà per titolo la “Cronaca Scandalosa”. Freddo e ghiaccio straordinario: il termometro sotto zero. Scoperta di nuove piramidi. Incendio di un teatro. “Virtuosi” ben pagati... e fischiati”.
E sotto il suo bravo epigramma, come questo:
Quattro cose assai modeste:
Guerra, peste... fame... e bile
Letteraria e femminile.
Per gli altri mesi di quello stesso anno si pronosticava, fra l’altro: l’introduzione dell’uso che le donne facessero la barba agli uomini; la comparsa d’una balena e due sirene nel Mediterraneo; l’eruzione (facciamo a buon conto gli scongiuri di rito) d’un nuovo vulcano; la risurrezione dei cavalieri (quelle gioie!) serventi; la verificazione e ispezione sui pesi e le misure (o avevano già a quell’epoca, i nostri graziosi bottegai, la cara abitudine di scamotare [eludere, n.d.r.]?); un grave concistoro e discussione animata sui mezzi di ravvivare la pubblica curiosità e ripopolare (di già! di già) il teatro; una rispettosa petizione di chi paga per sedere e vedere dalla platea, contro gli enormi cappelli femminili che lo impediscono; una tregua di Dio fra Classici e Romantici, grazie a un buttero rimasto sull’occhio destro della settima figlia di un capopartito; il suggerimento ai bottegai di cancellare (cose vecchie!) le iscrizioni francesi ed inglesi sulle porte de’ lor magazzini, perché si considera quanto in una città italiana, sarebbe conveniente di usare la nostra lingua che vale pur qualche cosa, e quanto disonori una piacenteria mal intesa verso de’ forestieri; un diluvio di poesie (oh fatalità dei ricorsi storici!) mistico-trascendentali seguito da osservazioni sull’inutilità della logica e della grammatica, e (udite! udite!) una forte imposizione sui celibatarj.
ANNO 1835
Per un centinaio d’anni ancora, invece, l’acqua doveva scorrere sotto i ponti, prima che soddisfazione fosse data all’ultimo postulato del Lunario reginiano; di codesto libriccino dalle paginette ruvide e oramai ingiallite, che ad ogni nuovo anno i nostri bisavoli aspettavano come la più ghiotta delle strenne, trovandoci di che passare allegramente le ore della veglia invernale, nella cerchia della famiglia radunata davanti al caminetto aristocratico o attorno all’umile braxëa.
Nella stanza, dove la luce fioca della lumeretta creava ombre gigantesche, ad ogni poco il lettore dava il segnale della risata, e ad essa faceva eco immediato uno scroscio d’altre risa su tutti i registri. Ma i vicini di casa potevano dormire sonni tranquilli, ché i muri divisorii avevano lo spessore di qualche spanna e i rumori morivano lì. Poi è venuta, purtroppo, la moda dei mattoni a coltello; e sono venuti il fonografo, la radio, l’iradiddio dei rompiscatole internazionali. Eh, ne leggeremmo delle belle se fosse ancora concesso di metter penna sulla carta al vecchio borghese che da quasi cento anni dorme il Sonno eterno nella chiesa dei Cappuccini,
Che visse con gran stento
Pe-a famiggia e per l’önô
Ma chi é morto assæ contento
Confidando ne-o Segnô.
Poiché egli, come fu amantissimo della domestica quiete, ebbe una vera fobia per gli assordanti rumori della strada.
Basta, a sincerarsene, scorrere i volumetti del suo Lunario, rivista d’un trentennio di vita genovese, denso dell’ingenuo folclore di un secolo addietro, da cui, leggendo, ci sentiamo fasciati come da un alone di patriarcale nostalgia.
Ora io me lo contemplo, questo nostro mediatore-poeta, nella fotoincisione che precede l’opera omnia, con quel suo visetto scortato da scopettoni denutriti; gli occhietti che sembrano, anche nel ritratto, irrequieti come due pulci in libera uscita; il collo solidamente protetto dal muro delle lattughe e dall’antemurale del bavero a forte altimetria. Dalla sua fisionomia traspare con evidenza pure il suo mondo interiore: la signorilità, la placidezza, l’arguzia, la ghiottoneria e, sopratutto, la coscienza a posto: cattolico militante ma non bacchettone; strettamente osservante del digiuno nelle vigilie comandate e, a suo tempo, sibarita da refettori frateschi; patriotta immune da tabe politica; mentore senza pedanteria; satirico senza veleno da acidi urici; il quale sapeva abilmente comportarsi col guardinfante del pari che con la tonaca, col pescecane di Banchi egualmente che col bozzolaro. Quanto al resto, fin troppo ossequiente all’imperativo categorico del crescite et multiplicamini, ché la sua collaborazione con Teresa Bianchi, arricchì la casata di ben undici esemplari, dei quali fece poi larga concessione al velo e alla cocolla [abito monastico, n.d.r.]. Il suo cospicuo contributo alla demografia non era tuttavia sufficiente per farlo ammettere a fruire di certe franchigie che allora il R. Governo accordava a chi aveva raggiunto la dozzina di figlioli. Ed ecco, in proposito, una sua supplica a Re Carlo Felice, al fine d’essere abilitato al godimento del sospirato beneficio:
Sacra reale Maestæ,
Ciù no pêu sperâ sto poæ
D’arrivâ a compì a dozzenn-a
Perché o passa a çinquantenn-a
E de ciù ûn brasso stroppiòu
Perché rotto, e mâ cûrou,
Chi o tormenta nêutte e giorno,
Né o pêu dâse ciù d’attorno
Comme primma e galoppâ
Da onest’ommo, e fâ o sensä:
Gran disgrazia chi o roziggia,
E fatale pe-a famiggia.
Ah! Maestæ, che sei ciammòu
Poæ do popolo, e adoròu,
Che ne-o nostro chêu regnæ,
Exaudî questo bon poæ,
Consûltæ o vostro gran chêu,
Fæghe grazia d’ûn figgiêu
Che da-o Çê ve benedixe,
Consolælo co-e “franchixe”
Che, vegnûo meno infelice,
O preghiä l’Onnipotente
Co a famiggia eternamente
Pe-o bon Re Carlo Felice
Che a nisciún mai grazie nega.
Altrettanto castigato nel discorso che nobile nel sentire, Martin Piaggio era puranco lesto a ripagare di moneta grossa qualche lingua sbardellata. Sicché a me è sempre piaciuto identificarlo con quel personaggio d’un suo sonetto, il quale, avendo pestato incautamente i calli a una virago da verziere e sentendosi da questa, inviperita, dar della capra:
No son crava (o ghe rispose)
Ma scommetto mêzo scûo,
Che se foîse vostro maio
Sæivo becco de segûo.
MARTIN PIAGGIO (da Wikipedia, n.d.r.)
A COMPAGNA RIVISTA MENSILE ILLUSTRATA
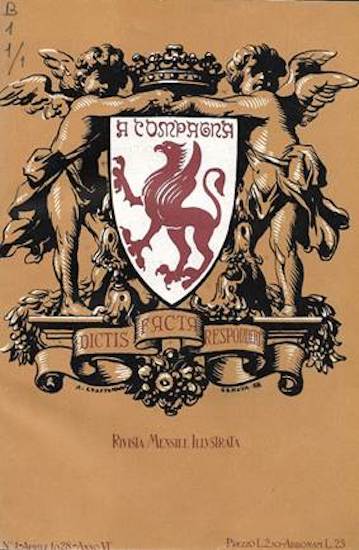
LA COPERTINA DEL PRIMO NUMERO

All’ing. Cesare Gamba che nelle sale di Palazzo Bianco, durante il memorabile ricevimento del 24 maggio 1926, gli consegnava il distintivo di socio della “Compagna”, S. E. Mussolini rispondeva poche, eloquenti parole: “Sono orgoglioso di appartenere alla “Compagna”.
Nel tracciare il programma di questa nostra rivista, rievochiamo, come il più sicuro auspicio per il nostro cammino, le incisive parole del più illustre dei compagni, il Duce, al quale inviamo il nostro primo saluto.
E un saluto rivolgiamo alle autorità politiche, fasciste, amministrative, sindacali, militari, giudiziarie, religiose, che reggono la Città, al Consolato magnifico, alla Consulta della “Compagna”, ai compagni, ai genovesi tutti, agli ospiti graditi di Genova, alle Associazioni regionali che come la nostra, si prefiggono il culto delle tradizioni della loro terra a maggiore gloria d’Italia, alla stampa cittadina che della voce di Genova è stata sempre così degna, autorevole interprete.
La nostra rivista si prefigge lo scopo di stabilire un efficace collegamento tra i “compagni” mediante la pubblicazione degli atti sociali, delle relazioni sui lavori compiuti dal Consolato, dalla Consulta, dalle diverse Commissioni; degli avvenimenti sociali di maggiore importanza, ecc. In una parola questa pubblicazione dovrà essere la eco fedele della vita dell’Associazione e per ciò recherà in ogni numero una parte ufficiale, redatta a cura della Cancelleria. Ma tale notiziario, se può avere un interesse pei soci, non basta a giustificare una pubblicazione che si rivolge in genere a tutta la cittadinanza genovese e ligure; e per ciò la rivista “A Compagna” sarà anche la illustrazione della storia e dell’archeologia ligure, delle tradizioni della nostra stirpe, dei monumenti che il genio e la opulenza degli antenati ci hanno lasciato, delle grandiose opere di carità che la munificenza antica e moderna ha costruito a vantaggio dei poveri, delle iniziative degne di maggiore rilievo nei campi più disparati dell’attività ligure, dalle nostre industrie poderose al vasto campo del commercio marittimo.
24 MAGGIO 1926 – S. E. MUSSOLINI DA UNA FINESTRA DEL PALAZZO DELLA PREFETTURA
SORRIDE ALLA BANDA DELLA “COMPAGNA” CHE PASSA SUONANDO “RUSTICANELLA”
La rivista si propone anche la illustrazione delle nuove opere pubbliche cittadine senza però invadere in minima parte il campo così bene mietuto dal Bollettino Municipale “La Grande Genova” al quale invia un plauso sincero per la cura con cui viene redatto nelle svariate sue rubriche. Né intende comunque la nostra pubblicazione varcare la sfera d’azione, prevalentemente letteraria ed artistica, di un’altra rivista mensile genovese “La Superba”, alla quale porge pure un cordiale saluto. E tanto meno vuole in minima parte assurgere alla trattazione dei problemi della politica, della scienza, della letteratura, i quali trovano degna sede nella Rivista “Le Opere e i Giorni” che, fondata e diretta dal “compagno” Mario Maria Martini, ha già da tempo oltrepassato i liguri confini per conquistare uno dei primissimi posti tra le riviste italiane.
Per la trattazione dei diversi temi ci siamo assicurata la collaborazione preziosa di competenti compagni, e in questo stesso numero i lettori possono già vedere alcuni articoli dovuti ad eminenti scrittori; specializzati nelle rispettive materie.
Consci che i tempi attuali, vibranti di meravigliosa attività, non si ammantano di vane parole, ma di fatti concreti, ci lusinghiamo che questa nostra modesta iniziativa, che abbiamo sviluppato per un debito di affettuoso omaggio alla memoria di Umberto Villa che ne fu l’ideatore, non abbisogni di illustrazione ulteriore, oltre il concetto animatore sopra enunciato. Esprimiamo solamente l’augurio che l’opera nostra non riesca indegna del pubblico genovese al quale ci rivolgiamo, fidenti nel suo appoggio e nella sua cooperazione.
LA DIREZIONE
IL TELEGRAMMA INVIATO DAL DUCE ALL’ON. BROCCARDI DOPO LE MEMORABILI GIORNATE GENOVESi
DISCORSI ALLA COMPAGNA
La parola di San Giorgio
«...Alla “Compagna”..., rispondono unanimi tutte le storiche campane della Liguria, che annunziano con esse, in questa nuova era del Risorgimento Italiano, nuove energie creatrici in mare e in terra, per la sempre più sublime ascesa di tutte le fortune nazionali».
PAOLO BOSELLI
Ieri tutto il Tempio sonava del carme secolare: tutti gli Italiani memoravano e propiziavano Roma Dea, restaurata al maggior Altare della virtù che vuole e sa ritessere le porpore, e rispiegar le vele, e rieducar, verdi, i lauri al Tricolore. Col vangelista nero e folgorante della Rinascita, erano tutti i credenti della Patria; il Tempio dai venti Campanili palpitava mirabile, superbo e uno nel Rito.
Oggi s’ingloria, San Giorgio, la tua vetta antica, onore della Basilica peninsulare, e questa n’è ancor tutta luminosa, ché il Campanile solare e marino dei Navigatori è gemma e faro, fortezza e squilla d’Italia.
Umili uomini oscuri ne saldano, col ricordo e l’amore, la pietra antica e sacra; coll’anima ne toccano il bronzo.
* * *
Restituire all’Italia, nella sua integrità spirituale tradizionale, uno dei suoi Popoli più gloriosi; mantenerlo sulla giusta e storica via del suo destino; risuscitare, a ciò, tutte le sue migliori energie; alimentarle e confortarle colla storia, colla tradizione, col costume, col linguaggio; conservarlo nelle tumultuose correnti d’immigrazione e nella massa sempre varia, e talora discorde, delle genti immigrate, uno di sangue, di volontà, d’anima e d’opera: costituirne – alto mirando, e al passato e all’avvenire – un patriziato conscio e responsabile della nostra nobile Terra, è l’ideale, lo scopo, la speranza e il volere della Compagna.
Tanto esprime la dichiarazione statutaria: tanto dev’essere sempre più fermo e luminoso e limpido. Tanto, senza nostre vane parole, comprese il Pilota dei Fatti.
* * *
Eppure v’è, ancora, un vulgo sciocco, di gazze, che parla e sparla delle Regioni collo sprezzo gassoso del pregiudizio ormai veto. A noi stessi, diremo, non a costoro, che più della pietra, dei marmi, delle tele, l’Italia deve vantare le sue Regioni: stupenda opera di natura e di moltanime umanità, di genialità italiana, di provvidenza divina; le sue Regioni che, diversissime, s’alleano a quell’unità unica d’italianità ch’è sinonimo – invano misconosciuto – della più varia e vivida intelligenza umana e civile.
Provvidenza sapiente, volle, come le terre, diversi gli uomini d’Italia; diverse – nei mutevoli pittoreschi scenari regionali – le attitudini, le attività, i costumi: vari gli spiriti, mirabilmente espressi negli usi come nelle opere; varia la terra armoniosa colle sue genti, le storie e le glorie delle collettività diverse, concordi coi loro individui.
Le diciotto Sorelle, tutte differenti e bellissime, costituiscono davvero una superba ghirlanda di maternità all’Italia! La gloriosa mutevol maraviglia delle gemme italiche oppone infimo danno al primato geniale che all’Italia venne da differenze così vivaci e caratteristiche, sì che il ligure nato sul mare, sull’azzurra cornice di rupi, e il pianigiano alacre nella feconda vastità padana, e l’arguto spirito frizzante nel giardin di Toscana, col calabro silvano e fiero, e tutti gli uomini e tutte le terre e tutte le arti e tutte le storie, e tutte le vite, e tutte le diversità, sono stupende leggi o privilegi, sorrisi e industrie di natura e di destino, d’umanità sagace e di provvidenza divina a far d’Italia mazzo unico d’ogni fiore umano...
Ciò non si comprese; si negò; si osteggiò per lungo tempo. E parve saggezza patriottica l’orrendo scempio della personalità regionale E titani monocoli, e pigmei senza lume, s’affaticarono – proprio bestemmiando il santo nome della gran Patria unica e somma! – a distruggere le piccole Patrie sua gloria e sua gioia; a demolire i naturali gradini per cui l’individuo, calpesti i bruti istinti egoistici, assurge; dalla famiglia al suo paese; dalla sua regione fino all’idealità più augusta, oltre cui è tutta l’umanità, e finalmente Iddio.
Nella furibonda quanto stolida guerra alle Regioni, che pur avevano saputo creare l’unità della Patria (proprio quell’unità nel cui nome dovevansi distruggere), alla ragion d’essere delle regioni e all’opportunità e all’utile di ben mantenerle, non si trovò voce e sapienza.
Non si vide e non si pensò, non si volle vedere e pensare ch’esse non erano forma d’artificio, convenzione geografica, espressione verbale, delimitazione amministrativa, bensì fatto fisico e psicologico; sostanza etnica, organismi naturali e vite storiche, realtà predestinate, plasmate nella stessa evidenza concreta e nella spiritualità della Penisola: terra e carne d’Italia; sangue e respiro della Patria; rappresentanti immediate tangibili d’Essa ai più; così come la nave Italiana è la patria italiana, presente e concreta nell’oceano.
Se la natura e la storia, il tempo e le stirpi crearono e mantennero le Regioni, come e perché tentar di distruggerle, o menomarle, anzi che usarle ad un fine?
Ciò non fu meglio ineditato. L’apologo del Romano parve applicato dallo stomaco, ovvero dal cuore – diciamo dai meccanisti del cuore! – a danno delle membra; rimproverando il braccio, la mano, il piede, il collo; di opporsi – colle loro diversità – all’unità della Nazione! Come se la Nazione bene unita dovesse equivalere a un cuore senza membra! A un blocco inarticolato, a un centro senza periferia! Per timore del vestito d’Arlecchino, si fece torto alle belle membra del corpo vivo.
* * *
L’Italia è fatta, bisogna far gl’Italiani...
S’abusò, in ogni scoletta, a sazietà, e in senso assoluto, pedantesco e alteratissimo, della frase dazegliana. Far gli italiani parve dover significare: distruggiamo i liguri, i lombardi, i napoletani, i veneti, i siciliani, per foggiarne, non gli Italiani di Milano. di Venezia, di Palermo... bensì un tipo ortodosso su misura, un’antologia antropomorfa di brani... (proprio di brani!) scelti dei vari tipi regionali, da distruggersi poi ad onta del passato, a obbrobrio dei secoli in cui le Regioni avevan dato Cesarea e Legnano, Ponza e Barletta, i Vespri e le Colonie d’oltremare! Un furore d’inintelligenza iconoclasta avventò tutti i declamatori, tutti i rètori del luogo comune, tutti i più ottusi pedagoghi a distruggere mura ciclopiche di sentimenti, d’attitudini, di consuetudini, di forte e vario vivere, che ai vaporanti cervelli ossessionati d’un uniformismo da orfanotrofio, sembravano barriere e catene, mentre che non costituivan meno della colonna vertebrale, del sistema osseo più intimo della grande Patria che poteva, finalmente, essere integrata fatta, cioè animata, inossa, da tutte le sue geniali diversità, con tutte le varie attitudini e forze, a nuova vita, a nuova storia, cui tutte le sue storie, tutte le sue vite, tutte le sue esperienze dovevansi rivolgere mirabilmente attive e concordi; per costruire, sì come sterratori e fabbri, muratori e falegnami, carpentieri e pittori, ingegneri e manovali s’adoprano all’edificio nuovo: saldo e armonioso.
Far gli Italiani doveva significare, per Massimo come per Goffredo, ridestare i Fratelli d’Italia; non distruggerne le molte vite, bensì rivolgerle – in cosciente armonia – a una maggiore; non distruggere per l’unità, le parti cui veniva mirabilmente a comporsi; non violentar le menti e i cuori, lor strappando pensieri e affetti foggiati nei secoli, bensì dai particolarismi chiusi portarli alla via maestra lumeggiata fiammeggiante della Patria, tutta acquistata e riconquistata.
Significava montare i pezzi, muovere l’inerte, riparare i danni; fare coll’esistente buono, migliorarlo – sempre migliorarlo – non annientarlo o sciuparlo, non mortificarlo come incompatibile colla creazione di cui era fattor primo; sollevare le genti men progredite d’Italia accanto alle più civili e prosperose; rilevarle dalle umiliazioni del servaggio, ripararne le devastazioni delle male signorie straniere; l’individuo rendere degno di tutto il Popolo e il Popolo illuminarlo colla luce dei più grandi cuori, delle più vivide menti che proprio le Regioni avevano dato al trionfo dell’Unità.
Menti e cuori d’uomini sommi, assolutamente diversi come le regioni da cui erano generati, e perciò forse maravigliosamente provvidi alla sacra causa.
Io non so chi non veda come la provvidenziale varietà spirituale delle regioni, esprimendosi nel pensiero e negli atti dei fattori dell’Unità, mirabilmente servisse proprio quella fusione d’Italia, di cui le regioni parvero poi dissolventi, vituperate. Certamente danneggiò la ragione il pensiero primo di coloro che, preoccupandosi della varietà grande delle popolazioni italiane, e considerando, com’era infatti, ingiustizia e ingratitudine somma tentar d’annientarla, e impossibilità per lo meno secolare, di acquistar loro un’uniformità, e dubbiosa praticità e utilità tentarlo, volevano, al primo fiorir dell’ideale di indipendenza, la confederazione degli stati italiani, e poi un’unità a spicchi o a cantoni, a foggia svizzera.
Dal Gioberti al Cattaneo, le regioni furon tanto e sempre presenti agli unitari, da divenir incubo di minaccia, di pericolo all’ideale supremo.
Il sospetto, il disamore, l’ostilità s’armarono tenaci, rimasero nel sistema politico, divennero vangelo d’educazione italianissima. Delle regioni sospiravasi in Parlamento e a scuola come di parenti indegni. Le membra, le parti d’Italia sembravano tutte vergognose! In buffo modo si raffazzonarono e antologiarono le istorie d’Italia; i fratelli mameliani furono siamesati retrospettivamente; la storia di Roma fu caudata d’un’infelice campionario senza sapore, colore e proporzioni delle vite regionali nei secoli. E si videro, si lessero, si studiarono nelle scuole i testi dov’erano dedicate dieci pagine a Venezia, Genova, Pisa superstiti della forza di Roma e seminario dell’avvenire, e forse dodici agli Scaligeri o ai Carraresi; dove Genova e i Genovesi comparivan soltanto per guerreggiare Pisa e San Marco, in conflitti idiotamente deplorati. Le guerre fraterne!... Non si vide altro delle storie dell’Italia luminosa e virile nel letargo buio!
Ma la zelante follia procustiana, non poteva contentarsi dei rapporti ch’ebbero nei secoli le varie parti d’Italia; d’un’armonia, che pur nelle divisioni e nelle varie vicende, mantenne – anche se non appariscenti, anche in occasionali contrasti – in legami di origini e di destino, le venturose sorelle.
Ah! quanto male fece questo zelo illogico alla Patria! I pezzi mal posti, o negletti, non possono valere alla macchina.
Qual folle imprevidenza indebolire, mortificare, traviare, artificiare la vita delle regioni singole – la loro vita naturale logica opportuna – nella convinzione sciocca di irrobustire il nuovo augusto corpo nazionale! Non per aiutar lo stomaco, ma precisamente per rafforzarlo, quei singolarissimi medici paralizzarono o atrofizzarono le membra!...
Chi volesse opporsi a questa verità storica, pur troppo ancor tanto evidente nei suoi effetti disastrosi, pensi alle sei o sette capitali – vere capitali non di staterelli ma di attività – rimaste come cuori inerti, come macchine dimesse, teste vuotate di cervello e di volontà poiché tutti i cervelli e tutte le volontà dovevansi foggiare in grande, e per tutti, e per tutto a Roma. A Roma, di quei tempi, impreparatissima: la verità non è irriverenza.
Centri di vita, di attività particolarissime; propulsori antichi costanti mirabili di energie che dovevansi esercitare, svolgere, afforzare su quei territori dove l’esperienza aveva lor segnati codici irrevocabili; genti che dall’ambiente e dalle sue esigenze prendevano incitamento, forze guide, dovettero abdicare le lor pur proprie virtù e subordinarsi alla volontà generica, in troppi casi inopportuna, dubbia o errante. Mare e fiumi, laghi e monti, industrie, traffici, navi; ogni vita antica e nuova dovette fermarsi il polso, spegnere i suoi fuochi. negarsil’evidenza, esasperare l’urgenza, in attesa delle provviste spirituali, legislative, tecniche, finanziarie di un centro ingombro e atono, dove Cavour non c’era.
Quell’accentramento era un ingorgo che si fece cronico e fu dannosissimo: l’iniziativa delle regioni, se non annientata, fu crudelmente impacciata, disagiata, sfavorita. Città use da secoli a volontà propria, ad azione immediata e diretta di previdenza e di provvidenza, che forse in brevi orizzonti, ma vicine e limpide vedevano le ragioni di lor vita, ascoltando e vigilando ben da presso il cuore e il cervello del loro organismo non vasto, ma proporzionato, logico, evidente, furono – quasi improvvisamente – invecchiate, fiaccate, esautorate nell’accidia spirituale dei subalterni; ricacciate da chi pensava di allargare le mura e gli spiriti al concetto più grande, alle più anguste miserie locali, talora con un burocrata accidioso e dieci intriganti. E le popolazioni divennero agglomerati di singoli egoisti, senza attività e responsabilità che oltrepassasse il nocciolo dell’interesse individuale.
Eccezioni qua e là di illuminati, di ambiziosi, di irrequieti, ma il folto regionale divenne di forza inerzia, da anima e animatore materia greve e lenta, or ripugnante e restia, or paziente passiva, or malcontenta e ostile d’una lontana tarda farraginosa, spesso opaca ed equivoca, spesso improvvida e inadeguata, volontà affollata, affaticata, sforzata: volontà di ufficio, provvidenza di maniera, competenza generica o di seconda mano, burocrazia non energia.
Qualche regione seppe adattarsi o reagire, e forse non fu estraneo all’assurgere di Milano il tirocinio di dominazioni straniere, per cui erasi l’industre regione già abituata a trovar forze e volontà sue da tener parallele, se non proprio da opporre, alle esigenze di dominanti lontane.
Enormemente soffrì invece la Liguria, l’albatro terrafermato.
Ora che Roma non è più vedova e sola con troppi; ora ch’è tornata Caput davvero, le regioni italiane, legittimate e confortate, trovano a Palazzo Chigi chi sa lo spirito profondo del mens sana in corpore sano di Giovenale. cioè che la testa è forte e sana, che il corpo è ben valido se il cuore, i polmoni, il fegato, non sono atrofizzati e buttati ai gatti.
L’Italia è il piroscafo maraviglioso, ma le sue Regioni sono gli scompartimenti stagni del transatlantico poderoso...
E se il Comandante è al suo posto, sul ponte di comando, l’alto pensiero scende alle macchine, indaga le stive; sa che la Bandiera sventola alta e sicura se sotto coperta non v’è un carico di addormentati, o di marinai franchi, sempre franchi di guardia, cui sembri merito e disciplina di aver disimparato vele e timone, di russare per non peccare.
Amedeo Pescio
A COMPAGNA: LA PROFUMERIA VITALE
A COMPAGNA
In fondo la locandina della mostra
«Sulle tracce dei pastori»
organizzata dall’Archivio di Stato di Genova
Cari soci e simpatizzanti, proseguiamo con l’iniziativa di proporvi ogni martedì la lettura di un articolo scelto tra quelli pubblicati nelle prime annate del nostro bollettino (1928-1933), cercando di variare gli argomenti trattati. Buona lettura! Chi volesse leggere gli articoli già inviati segua il link: http://www.acompagna.org/covid/index.htm
Colgo l’occasione per ringraziare la Gran Cancelliera Isabella Descalzo per l’idea di mandare questi articoli e per la cura con la quale li prepara.
Franco Bampi
Il pioniere genovese delle essenze profumate
La Profumeria Vitale
Articolo a firma Matteo Ferdinando Canessa, pubblicato sul bollettino
n° 6 – Giugno 1929
1873: - Albori di vita nel ritmo della vita. In Genova, perla Mediterranea, rivivono nella nuova vita dello stato nuovo le glorie del risorto San Giorgio. Artieri e calafati armano di pece e di ferro le galee nuove, dalle quali sorgerà l’impulso a percorrere le vie note dell’Oriente per stringere vincoli nuovi, per rinsaldare amicizie coll’opera feconda del lavoro con le genti d’oltremare. Mentre fervono i magli della prima rinascita, gli artigiani nelle piccole botteghe piegano il rame, filano l’argento, distillano i profumi che le navi nuove porteranno lontano, a significare la capacità possente e paziente del popolo tenace.
Intanto la dama nei palazzi di marmo sontuosi d’oro, alti di luce nel sole, fra i tappeti d’Oriente e i merletti di Smirne, bruciava nelle conchiglie cinesi profumi che la diligenza aveva portato d’oltre alpe.
Ma si risvegliava il senso di indipendenza come dopo le grandi guerre ed i grandi patimenti: e come l’artigiano filava l’argento, e come batteva il rame, e come torceva il cuoio, e come modellava la creta, così l’artigiano di Liguria toglieva dai fiori della sua terra il profumo per chiuderlo nelle ampolle ed offrirlo alla sua dama.
È l’elogio della piccola industria, dell’artigianato, del lavoro minuto, animato dalla grande fede e da un senso d’arte e di poesia.
Piccole stanze buie nei vicoli, cataste di fiori, lambicchi, mortai pulsanti, uomini come automi a frantumare la radice odorosa ed a renderla polvere, profumi come stille di rugiada raccolti nel vetro soffiato dal maestro vetrario della rivale di ieri, Venezia. In alto, nel buio più fitto l’icona di San Giorgio ed il lume tremolante sulla operosità dell’uomo.
Tale doveva essere la fucina dalla quale solo per virtù d’amore doveva nascere una industria vera; tale doveva essere all’inizio la fucina dove per la prima volta si composero le essenze per creare il profumo che oggi è cercato ed usato, e che ha varcato sulle galee nuove i confini dei nostri mari. In tale ambiente nacque l’Acqua Antiqua, la deliziosa acqua per toeletta che Vitale, maestro d’arte e di profumi, animato dal sogno tutto fiori
della terra ligure, seppe realizzare con tenacia e con sacrificio.
ALESSANDRO VITALE, FONDATORE DELLA DITTA
Le difficoltà di imporre un qualche cosa di nuovo erano tanto maggiori in quanto in passato l’Italia mostrava di avere una certa prevenzione contro i prodotti nazionali, segnatamente nel campo della profumeria, prediligendo le marche straniere.
Per riuscire ad imporre il proprio nome nel campo dei profumi bisognava dunque vincere un secolare preconcetto, facendo bene apprezzare prodotti originali e perfetti. Vanto della Ditta Vitale di Genova è appunto quello di non aver proceduto mai con criteri di imitazione, ma di aver cercato invece con prove e contro prove costanti nella difficilissima chimica delle essenze e dei profumi la vera verità geniale. L’Acqua Antiqua non solo fu salutata con crescente favore in Italia, ma per le sue eccezionali particolarità fu in breve apprezzatissima anche all’estero, e se ne avviò una considerevole esportazione nei principali stati di Europa e d’America.
Incoraggiata dall’accoglienza fatta dal gran pubblico elegante all’Acqua Antiqua, la Ditta Vitale ebbe la genialissima idea di applicare lo specialissimo ritrovato ad altri prodotti per toeletta. Fu così che in breve creò: l’Essenza per fazzoletto Antiqua, lozione per capelli Antiqua, il sapone purissimo Antiqua, la crema per la pelle Antiqua, la polvere di riso Antiqua, lo shampoing Antiqua, l’elisir dentifricio Antiqua, la pasta dentifricia Antiqua, il talco Antiqua. Dopo essersi affermata in tutte queste specialità della serie Antiqua, la Ditta Vitale coltivò di preferenza gli studi per altre essenze odorose, ed altri profumi, animata sempre dal lodevole intento di raggiungere le doti principali che debbono avere i prodotti di simile genere, cioè la persistenza, la signorile finezza e l’assoluta originalità.
IL NEGOZIO DI VIA CARLO FELICE
Così ebbero vita, a distanza di qualche anno l’una dall’altra, e si affermarono nel corso del tempo le specialità che presero l’augurale nome di Gloria: quelle chiamate Senza Nome, Malia, Lolita, Rose Rosse, Viole di Parma, Vero Mughetto, Tau, anche queste applicate poi, perché salutate dal generale consenso, a tutte le varietà di prodotti di toeletta. A queste creazioni d’incomparabile finezza seguirono quelle dell’Acqua di Colonia distillata dai fiori di Pegli, speciali saponi per toeletta, l’elisir dentifricio, la pasta dentifricia, la polvere dentifricia. In tal modo la Ditta Vitale conseguiva il fine propostosi: di dotare cioè la sua speciale industria di tutti i prodotti occorrenti alla toeletta. Una delle particolarità della Ditta Vitale è quella di presentare alla sua fida clientela i prodotti con una perfetta forma di estetica e di signorile buon gusto; le bottiglie, le anfore, i vasetti, gli astucci, gli stessi involucri di rivestimento hanno tutti una impronta di particolare distinzione.
A tanto fervore di sorrideva finalmente la gioia del trionfo sotto la specie purissima del plauso di re, di personalità del mondo culturale, scientifico, letterario, diplomatico di tutto il mondo.
Scriveva Novelli, il comico finissimo: “Caro Vitale, ho provato la vostra Acqua Antiqua e sento già che né io né la mia famiglia potremo d’ora innanzi farne più a meno”. E Tina Di Lorenzo, questa squisita artista che si è allontanata dalla scena ancora nella pienezza della capacità quasi a rendere più bello il ricordo dei suoi trionfi si dichiarava ammirata per l’Acqua Antiqua che, essa scriveva: “rappresenta l’elemento più importante e direi indispensabile per la mia toeletta”.
Qualche anno più tardi ancora Tina Di Lorenzo quando apparve la creazione Senza Nome, così si esprimeva: “senza nome? uno ne ha, il solo possibile per tale profumo: soavità”. Virgilio Talli maestro d’arte e di grazia, a proposito del profumo Gloria diceva meravigliosamente: “date tutta la gloria a chi seppe creare un profumo di tal nome e di tanta dolcezza”. Paola Borboni, la bella Paola è una consumatrice dell’Acqua Antiqua, e diceva una sera in confidenza che tre cose amava al mondo: la sua arte, la sua mamma e l’Acqua Antiqua di Vitale. Amerigo Guasti, un altro scomparso, ma vivo nel ricordo di quanti lo conobbero sulla scena e fuori, scriveva così: “Caro Vitale, mandatemi subito una bottiglia della vostra deliziosa Acqua Antiqua. Sono stato di passaggio a Genova e non ho avuto tempo di passare da voi a prenderla: se non faccio vedere la vostra Acqua Antiqua, nessuno crederà che io sono stato a Genova.
Non cito le frasi lusinghiere degli altri maggiori, della Melato, della Galli, della Pavlova, del Falconi, del Sabatini, di Marcacci, di Benassi, di tutti gli astri del nostro teatro di prosa e del teatro di lirica.
Fra le maggiori attestazioni di cui si vanta la Ditta Vitale è certo quella di aver servito la defunta Regina Margherita, la Duchessa di Genova, e di essere onorata di ordinazioni dalla Real Casa del Principe Umberto.
S. E. Benito Mussolini gradiva un omaggio dell’Acqua Antiqua, e inviando una sua fotografia firmata, incoraggiava nella produzione, lodando la composizione e l’elegante dignità della presentazione.
Pitigrilli, il sereno pessimista, l’umorista pungente e finissimo, impareggiabile nel sarcasmo, scriveva: “I fiori sono un ornamento da carro funebre: ciò che hanno di meglio si trova nelle essenze di Vitale”. L’umorista non si è smentito.
MICHELANGELO VITALE
Animatore di tanta evoluzione fu Michelangelo Vitale. Egli, che aveva raccolta bambina la fabbrica dei profumi Vitale, e che con studio assiduo, con fermezza di propositi, con mirabile purezza di sentimenti era riuscito a farla assurgere a dignità d’arte e di lavoro, egli che tutto aveva dato per la gloria del suo nome e della sua patria, veniva privato del godimento di vedere il progresso meraviglioso di ogni giorno e di accogliere il plauso del mondo per la sua fatica. Sono quasi quattro anni. Quando nella mente geniale del Cav. Michelangelo Vitale andavano prendendo forma e vita nuove manifestazioni di lavoro, di arte e di gloria, la morte terribile, brusca, crudelissima, troncava la sua nobile esistenza. Di questa preparazione ad ulteriore lavoro è espressione la modernissima fabbrica che Egli aveva fatta assurgere negli anni che precedettero la morte, nella ridente collina di Albaro.
LA GRAZIOSA PALAZZINA DELLO STABILIMENTO VITALE
Ora Egli non è più, ma il buon seme gettato è stato raccolto dai suoi fedeli collaboratori di ieri, che riconobbero in Lui un maestro, un padre, un animatore di lavoro. Nelle nuove e luminose sale il ritmo della vita è tumultuoso.
L’artigiano del 1873 è divenuto un gigante. Non più piccole stanze buie, ma spazio e sole; non più mortai echeggianti la loro voce rauca sotto il peso del pestone di bronzo, ma canzoni di motori, scintille e faville di dardi elettrici nel sole, fragore di uomini e ronzio di cifre vertiginose sulla macchina da scrivere, accanto a diecine di donne che accarezzano il collo della bottiglia odorosa coi nastri e con le mani delicate, come se accarezzassero il volto del promesso sposo, e ancora martellare veloce di colpi sulle casse per l’America, per l’India, per la Cina, per tutto il mondo, a portare sempre più oltre, sempre più alto il dolce nome d’Italia.
Come allora, in alto, l’icona di San Giorgio splende e lancia fiamme e diffonde luce sull’operosità dell’uomo.
Per il salvataggio degli equipaggi delle navi
L’apparecchio ideato da un Genovese
Articolo pubblicato sul bollettino n° 4 – aprile 1930
Il capitano marittimo G. B. Tarantini, nato a Genova nel sestiere di Pré da famiglia marinara, ha studiato e brevettato fin dal 22 gennaio 1929 un apparecchio speciale destinato al salvataggio dell’equipaggio delle navi.
L’invenzione del nostro concittadino e “compagno” consiste essenzialmente di uno scafo (1) di forma pressoché sferica, costruito in lamierino d’acciaio e la cui parte inferiore porta una base piana (2) che serve a far poggiare l’apparecchio sulla coperta della nave.
ln detto apparecchio prendono posto, attraverso un’apertura (3) ermeticamente chiudibile dall’interno e dall’esterno, gli ultimi uomini dell’equipaggio e gli ufficiali rimasti a bordo quando già la nave è in procinto di affondare. Calato in mare o trascinato nei gorghi della nave che si inabissa, l’apparecchio risale alla superficie (per il noto principio per cui un corpo galleggia quando il suo peso è inferiore a quello dell’acqua spostata) e galleggiando rimane nella sua posizione verticale in virtù di una riserva d’acqua potabile posta nella base (5) dello scafo divisa in scompartimenti. Nel caso che l’acqua venisse a mancare se ne può immettere dell’altra marina affinché le condizioni di equilibrio non vengano a mancare.
L’apparecchio così galleggiante può rimanere per molto tempo in acqua proteggendo dalle intemperie gli uomini in esso rinchiusi. Si può anche renderlo atto a navigare munendolo di un motore (10) a benzina o elettrico che comanda un’elica di propulsione, in tal caso si può sistemare un timone per il governo e dalla parte opposta uno spartiacque (22) mobile o fisso.
Come si vede dalla figura, nella parte alta sono sistemati 4 oblò (4) chiudibili ermeticamente dall’interno, 2 ganci (12) per sollevare l’apparecchio a bordo della nave salvatrice, 4 fari elettrici (11) per le segnalazioni notturne, 1 campana (15) che suona per il solo dondolio dell’apparecchio, 1 asta (16) con bandiera e lateralmente 2 aste (14) reggenti l’aereo (13) di una piccola stazione radiotelegrafica a onde corte.
Lateralmente si osservano degli anelli (8) portanti dei cavi sganciabili dagli oblò e muniti alle loro estremità di gavitelli: per formare un convoglio: poco al disopra del galleggiamento sono applicati dei parabordi (19) di sughero fasciati in tela per proteggere lo scafo dagli urti, ad essi sono fissati dei pezzi di corda (20) portanti dei bilancini di legno (21) che vengono a trovarsi in corrispondenza del livello dell’acqua e che servono di sostegno per i naufraghi all’esterno.
Nell’interno è collocato un tavolo (18) pieghevole che può servire per la stazione radiotelegrafica, una cassa (16) per la benzina, dei sedili (17) nel cui interno sono poste le provviste.
Queste sono le principali caratteristiche dell’apparecchio ideato dal cap. Tarantini.
Noi auguriamo all’inventore, che si è preoccupato essenzialmente di ridurre le perdite di vite umane nei naufragi, che il suo apparecchio, che attualmente è allo studio presso l’ufficio del Genio Navale, possa venire applicato nella nostra Marina Mercantile.


 Mara Musante
Mara Musante










